In una mattina dell’estate del 1941 io stavo sul poggiolo esterno di legno della casa di mia madre. Il sole dolce e forte del Friuli batteva su tutto quel caro materiale rustico… su quel poggiolo o stavo disegnando (…), oppure scrivendo versi. Quando risuonò la parola ROSADA. Era Livio, un ragazzo dei vicini oltre la strada, i Socolari, a parlare. Un ragazzo alto, d’ossa grosse… proprio un contadino di quelle parti… ma gentile e timido come lo sono certi figli di famiglie ricche, pieno di delicatezza. Poiché i contadini, si sa, lo dice Lenin, sono dei piccoli-borghesi, tuttavia Livio parlava certo di cose piccole ed innocenti. La parola ROSADA non era che una punta espressiva della sua vivacità orale. Certamente quella parola, in tutti i secoli del suo uso nel Friuli che si stende al di qua del Tagliamento non era mai stata scritta. Era stata sempre e solamente un suono. Qualunque cosa quella mattina io stessi facendo, dipingendo o scrivendo, certo mi interruppi subito. (…) E scrissi subito dei versi, in quella parlata friulana della destra del Tagliamento, che fino a quel momento era stata solo un insieme di suoni: cominciai per prima cosa col rendere grafica la parola ROSADA.
Con queste parole tratte da Empirismo eretico di Pasolini del 1972 potremmo cominciare, se volessimo proprio cercare un punto d’inizio, a parlare della poesia dialettale da Pasolini ai giorni nostri, concentrandoci non sulla poesia nazionale ma su quel vivissimo quanto aspro territorio che è il Friuli. Non che in Friuli non esistesse già un certo filone dialettale, una parlata quanto una scrittura, ma è certo che solo dal poeta casarsese si cominciò a pensare al friulano come a una lingua altra, uno strumento proprio. Per cui la domanda iniziale forse dovrebbe essere un’altra, tanto per rimescolare ancora un poco le carte: cos’è il friulano?
Dirò subito che il friulano come lingua dialettale, se osserviamo la poesia, non esiste. Esistono i friulani, le molte lingue. Chi mastica un po’ di poesia contemporanea avrà già colto l’enorme parallelo con la poesia nazionale, appunto poesia plurale, fatta di una moltitudine di voci. Tale è il friulano, una moltitudine di lingue che per la maggior parte vengono parlate in piccoli/piccolissimi centri abitati. Paesi, paesini. Ma questa supposta inesistenza del friulano come lingua, a cui corrispondono delle effettive esistenze di moltissime lingue friulane talvolta letteralmente incomprensibili tra di loro, ha un’ulteriore caratteristica che complica ancor più la stupefacente inesistenza/esistenza di questa lingua. È di fatto una lingua giovanissima.
Una lingua giovanissima che viene parlata da secoli, intendiamoci bene. Ma se prendiamo ad esempio la zona pordenonese (cittadina da cui io provengo) dobbiamo constatare che a inizio novecento non vi si parlava il friulano, ma il veneto. Parliamo di cento e poco meno anni fa. Mia nonna, morta da alcuni anni, pordenonese di nascita di fatto parlava il veneto. Ma se osserviamo lo stesso dialetto pasoliniano non possiamo non ricordare che era un casarsese venetizzato, preso e costruito con l’obiettivo di creare una lingua nuova. Viene quasi da pensare al dialetto usato da Dante. Ma nel nostro caso specifico non c’è stata un’unificazione all’insegna di un’elevazione della lingua nuova, anzi. Alla ricerca della lingua nuova ha corrisposto un’esplosione di micro lingue letterarie tutte di pari valore perchè giustificate dal motivo per cui venivano utilizzate. Mi viene da pensare a Pound, al caro Eliot, a quello sfascio delle forme che in un momento di languore e decadenza serviva a far sopravvivere la poesia. Distruggerla per darle vita nuova. Cercare una forma nuova. Da qui quell’enorme opera dell’umanità che è The waste land.
In questa prospettiva acquisisce un senso fortissimo, importante, potremmo dire necessario, la scelta dell’utilizzo del dialetto. E tanto più il dialetto diventa particolare (perchè usato da poche persone in un piccolo centro) con tanta più forza diventa costruzione di una nuova forma, di un nuovo modo di far sopravvivere la poesia. Il dialetto preso dalla casa materna, dagli anziani che parlano nei bar, dalle serate a camminare nei campi, viene elevato a lingua letteraria, reso ancor più specifico e particolare attraverso la lama linguistica. Per cui tale poesia incontra uno scoglio: la traduzione. Tale poesia dialettale la sanno leggere perfettamente le persone che vivono nel paese del poeta, ma al di là dei suoi confini diventa un suono tanto agrodolce quanto incomprensibile. Citando Gian Mario Villalta potremmo dire un dialettaccio.
Se non che nel 1968 un certo Zanzotto, non friulano ma veneto (e qui ricordiamo ancora che il friulano viene comunque dal veneto), comincia a parlare di petèl. Le Poesie a Casarsa di Pasolini sono uscite nel 1942, l’Academiuta di lenga furlana viene fondata nel 1945, La beltà zanzottiana è del 1968 e l’Empirismo eretico pasoliniano (da cui ho tratto il brano iniziale di questo articoletto con quell’emblematica citazione del termine Rosada) è del 1972. Il tutto per dare un significato nuovo a questo dialetto/moltitudine di dialetti friulano.
Per fare un po’ il punto della situazione e quindi avventurarmi in questa poesia dialettale post pasolinana (Pasolini decretò la morte dei dialetti ma sappiamo che non aveva proprio ragione), mi viene in aiuto un’intervista fatta ad Amedeo Giacomini, grandissimo autore e promotore della poesia friulana, curata da Paolo Di Stefano nel 2002. Che è veramente da leggere: Tirando le somme, passati i sessanta, dovrei riconoscere che sia proprio quest’ultimo la mia lingua madre, ma la confusione rimane e anche mi pesa. Perciò, riferendomi al fare poesia, preferirei non distinguerla in dialettale o in lingua, ma (se c’è), preferirei parlare di poesia tout court, di un modo cioè di considerare il mondo (o semplicemente un paesaggio interiore), esserne dentro nel presente fino in fondo e darne (alle quattro persone che magari ti leggono) qualche strumento per capirlo o magari anche per modificarlo. Una lingua, ne sono convinto, ti trova, non sei tu a cercarla. Per attenermi all’aspetto più problematico del tema di oggi, dirò che fu Pasolini, con la scorta del suo pascolismo di fondo, a eleggere la lingua materna “lingua della o per la poesia”. A giustificarlo contribuirono alcuni suoi traumi psicologici non superati e la situazione storica (il fascismo, la guerra) in cui operava: il friulano (il casarsese che nemmeno parlava) venne, per lui giovanissimo, a opporsi all’italiano (in cui pure erano state scritte le sue Poesie a Casarsa, poi tradotte servendosi principalmente del contributo di amici e del vocabolario), in quanto questo era diventato insopportabile nella volgarità fascista: non lingua di popolo ma espressione della retorica stupidità piccolo borghese. Il casarsese fu, dunque, dal punto di vista letterario, per sua stessa definizione, ricerca di una lingua vergine, superiore anche a quella degli ermetici che voleva aggirare, espressione di un popolo antico e nuovo, forte della sua fedeltà a valori concreti: ideologicamente, un fatto di Resistenza. Per quel critico acuto che già egli era, il casarsese (un dialetto molto venetizzato del friulano centrale, ricco di dittonghi dolcissimi, di finali tronche alquanto musicali, che ben sposavano la ricerca fono-simbolica delle intenzioni poetiche), a voler essere cattivi, fu persino una decisione oculata, quella che andava bene in quel periodo, in cui l’ermetismo era ormai alle sue strette finali, una decisione atta persino a nascondere (o a mascherare) nella sua fonalità squisita, traumi psichici e umani che erano tipici di un sé Narciso. Gli permise (il casarsese) di creare insomma un teatrino idillico ed edenico in cui l’Io-Narciso e la meglio gioventù che lo circondava rivestivano panni angelici, ben lontani da quelli che, nella sua vita grama, nella sua miseria, quella gioventù veramente era. Un teatrino, dunque, sostenuto – e sta proprio qui, a parer mio, la lucidità letteraria del poeta – dal ricorso, in nome degli intenti di purezza e verginità, ai lirici primitivi (i provenzali, soprattutto), innestato alle traduzioni in friulano dei moderni, a partire da Pascoli, appunto, assunto (senz’altro grazie agli insegnamenti di Contini) quale zoccolo duro della modernità decadente. In altre parole, ancora e fuori dal ricorso al friulano, fu per lui un atteggiamento storicistico che anticipava il suo neosperimentalismo futuro. Io ho molto amato quel teatrino, in primo luogo perché elevava la poesia in lingua friulana a livello finalmente autonomo e, per cultura, europeo, quella poesia che, quasi parallela, per antichità e durata costante, a quella nazionale, era invece caratterizzata dal provincialismo: vernacolare in senso stretto, poesia da ‘tavolata’, insomma, di imitazione verso il basso, prodotta da nobilotti imparruccati e da borghesi in cerca di stima e protezione per divertire nei convivi padroni, amici e sodali. In secondo luogo, l’ho amato perché da quel teatrino ho a lungo dipeso.
[…]
Ma, in effetti, se io penso alla letteratura friulana, che dura dalla fine del Duecento, praticamente, con le prime poesie di natura provenzale, noto che la poesia friulana, quella che un pochino conta, è nata nei momenti di attrito sociale, è nata con le guerre, con l’occupazione veneziana del Friuli, è nata con il fascismo, è nata con il terremoto, sempre in quei momenti lì, quando ci sono questi stimoli esterni che colpiscono il poeta o chi parla. Prima ho cercato di dire che il poeta è colui che attraversa un mondo, un paesaggio interiore, o esteriore, come volete, che cerca di starci dentro, di dare le chiavi per capirlo e modificarlo. La poesia nasce proprio in queste situazioni, non ci sono problemi legati alla filologia: se dobbiamo essere legati alla filologia, rispondendo all’amico Giudici, possiamo replicare: “Prova a farlo cantare, il friulano, se sei capace”. È una lingua piuttosto dura, in ogni senso. Se non lo inventi, se non lo rifai tutto, il friulano non canta, non viene. È come soffiare in una zucca, più soffi, meno fischia, ecco.
Questo per dire un concetto importantissimo del dialetto/dialetti friulano: nasce da una crisi. Anzi, da tante crisi: le guerre mondiali, la ricostruzione, il terremoto del 76, l’industrializzazione che ha cambiato tutto, il paesaggio in primis (tema tanto caro a noi friulani), le persone (un altro grande poeta, Franzin, anch’egli veneto e non friulano come Zanzotto, parla in maniera eccelsa di queste fabbriche che consumano l’umanità delle persone). Fa il verso a questo concetto il nostro già citato Villalta che anch’egli in un testo dialettale proclama la morte del dialetto, e che nella voce Poesia dell’enciclopedia Treccani scrive: In Italia risultò più profondo il “trauma” (Pasolini) relativo alla rapida trasformazione economica del Paese, che vedeva una civiltà contadina affrontare l’impatto dell’industrialismo e dei nuovi mezzi di comunicazione: fu il cosiddetto boom economico e demografico, con l’espansione dei consumi, l’abbandono delle campagne, la migrazione interna, il concreto impegno politico per una reale scolarizzazione di massa. Si parlò di una “mutazione antropologica” (Pasolini), che aveva sconvolto i costumi e la mentalità degli italiani, aveva intaccato tradizioni secolari e, di conseguenza, aveva determinato “una rivoluzione della mente, una svolta intellettuale” (I. Calvino), tale da mettere in crisi i consueti parametri di interpretazione dei fatti culturali.
Un susseguirsi di crisi dunque, di traumi, di strappi, di lacerazioni e ferite, di cicatrici, e sul tavolo una lingua/tante lingue nuove pronte a dare forma linguistica alle cose perse e al senso della perdita. Perchè in qualche modo tutte quelle cose perse erano cose naturali in confronto alle cose nuove, artificiali, frustranti. Erano cose profondamente umane, originarie, pure nel loro essere vere, essenziali (i dialetti friulani sono tutti molto essenziali), erano esse stesse petèl. Da qui l’esigenza di un dialetto sempre più particolare e sempre più privato intendendo il “privato” come “proprio di una piccola comunità”, utile a trattenere le cose di una volta, i campi sterminati dalle fabbriche, i dialoghi zittiti dalla nuova società, i concetti e i modi di vivere sempre più sfaldati dalla modernità e dalla globalizzazione. Perchè trattenendo la lingua, rendendola letteraria, eterna, si trattengono anche i valori su cui quella lingua si era costituita. Valori aspri, duri, da una terra ruvida amata e odiata quale è il friuli, da sempre terra di partenze e di ritorni. Da questo Giacomini, Bartolini, Villalta stesso, per dire qualche nome.
Per fare una digressione forse un po’ fantasiosa vorrei raccontare che c’è un poeta, che ormai sta facendo la storia della letteratura poetica italiana, friulano (dalla provincia di Udine) emigrato da anni in altre zone d’Italia, che ha da poco pubblicato un libro che se vogliamo esemplifica benissimo l’azione del dialetto usato da questi nostri poeti. Tersa morte di Mario Benedetti (2013) prende di fatto il momento della morte umana, quell’attimo del passaggio dalla vita alla non-vita, e lo espande a dismisura cogliendone tutte le sfumature, le dinamiche. Se vogliamo è questo il dialetto friulano che canta il paesaggio perduto, trattenuto nella memoria come verità nelle sue bellezze e asperità ma perso per sempre, valorizzato proprio dalla perdita, vissuto in questo momento estremamente ingrandito e duraturo di una morte che continuamente si rinnova.
Ma come ho detto qualche riga fa il Friuli è una terra ricchissima di poesia, benedetta dalla nascita in seno e vicino di poeti immensi quali Pasolini e Zanzotto, dalla costituzione di grandi festival letterari come Pordenonelegge che rendono la letteratura friulana estremamente dinamica e in continua evoluzione. E in questo arriviamo a Vit, Cappello, Vallerugo, Tavan. Poeti che sono andati oltre il canto del perduto espandendo la lingua verso un orizzonte futuro, componendo lingue che partono dal passato ma che guardano al domani, alla lingua stessa. Giacomo Vit ad esempio oltre a al paesaggio cita i bambini, i portatori del petèl, del dialetto originario, e li fa parlare. Ma non sono più bambini friulani o bambini di un momento storico friulano. Sono i bambini della guerra, sono tutti i bambini che muoiono in guerra. Pierluigi Cappello dal canto suo eleva la lingua, una lingua come detto asprissima, a canto, spesso lirico, dolcissimo. Non disdegnando comunque il tema costante della perdita del tempo, delle storie del passato. Ida Vallerugo, mestra di poesia, con l’immenso e mai abbastanza elogiato Maa Onda crea una vera e propria poetica da Sidney a Meduno e oltre, da sua nonna (Maa) a se stessa, in un’opera che definire metafisica è quasi riduttivo per quanto necessario. Per giungere infine all’eretico, il barbaro, il bambino mai cresciuto Federico Tavan. Di cui ho già abbastanza parlato altrove e per cui non ripeterò le stesse cose. Poeta che in qualche modo ha la caratteristica di non avere alcuna ricerca linguistica ma un folcloristico istinto scrittorio e poetico. Parla di Andreis nel dialetto di Andreis. Profetizza che se non scappi da Andreis diventi Andreis, e scrive anche che sogna di scappare in cielo con un’astronave (la naf spazial) per sfuggire agli umani. Dicendo quasi che se non scappi dal mondo diventi il mondo. Lui che senza mezzi termini e con l’occhio lucido della pazzia (che lo rende paradossalmente meno miope dei sani) ha scritto e cantato della differenza, dell’assurda differenza di un uomo inadatto alla normalità ma che si accorge che è solo un caso il suo essere inadatto, caso che può capitare a chiunque. Per chiudere con la cifra della sua poesia: un’amore per la bellezza della vita a prescindere, e nonostante tutto.
Ora seguiranno a completezza di questo articoletto alcune brevi schede che senza mezzi termini devono molto a quello stupendo libro che è Poeti del Friuli tra Casarsa e Chiusaforte di Anna De Simone, che ringrazio. Non tratterò tutti i poeti friulani come non li ho trattati fino ad ora, ma solo alcuni, giusto per dare un assaggio di Friuli senza annoiare troppo il lettore. Augurando che il lettore stesso abbia colto la grandezza di questo momento dialettale che è la pluralità delle voci friulane, e delle poetiche friulane. E delle sue intelligenze, che sono l’anima e la forza di una terra che da sempre ha saputo affrontare a testa alta le crisi ricostruendosi continuamente, appena concedendosi il tempo per piangere.
Amedeo Giacomini è nato a Varmo in provincia di Udine nel 1939 ed è morto a San Daniele del Friuli nel 2006. Ha pubblicato il volume di poesie in dialetto Tiare pesante nel 1976, anno del terremoto. Ha curato la fondamentale rivista di promozione della poesia dialettale “Diverse lingue” (Campanotto Editore). Di lui Gian Mario Villalta ha scritto, nella sua introduzione a Antologia privata. Poesie in friulano (1977-1997) edito nel 1997: L’esordio di Giacomini in friulano, con “Tiare pesante”, porta la data del terremoto che devastò il Friuli reale così come, e definitivamente, il Friuli sognato della persistente mitologia vernacolare. È una data che ha un valore cronologico inequivocabile e allo stesso tempo segna un profondo discrimine simbolico: il 1976, quando il difficile equilibrio di crescita di una terra segnata da cicatrici secolari di emarginazione e di abbandono viene violentemente lacerato, facendo riapparire intatti i fantasmi di un passato ancora vivo nella memoria dei friulani. Viene sopratutto in rilievo la grande crisi di identità e di valori, la faglia dolorosa di inappartenenza che percorre i paesi, le forme di vita sociale, e che divide trasversalmente le generazioni: il frutto di una caotica e troppo veloce modernizzazione, che la sottile crosta della retorica della ricostruzione non riesce a nascondere. Giacomini dà figura a questo dolore e a questo disagio, con toni e accenti accorati e insieme violenti, componendo le voci dissonanti, ma venute a congiungersi, dell’antica vicenda di sofferenza del friulano in guerra con il proprio mondo e della presente emarginazione dell’intellettuale. È un Friuli vero, in una lingua vissuta e sofferta, dove il lirismo porta a volte il segno dell’eccesso espressionistico, che si contrappone apertamente, pur non potendone ignorare la lezione, al Friuli sognato di Pasolini.
(Antologia privata. Poesie in friulano, Amedeo Giacomini, Moby Dick 1997)
Nello stesso anno di Giacomini è morto un altro grande dialettale friulano, Elio Bartolini, nato fra l’altro nello stesso anno di Pasolini: il 1922. Di lui Franco Brevini, ne Le parole perdute (Einaudi 1990) dice: Si ha l’impressione che all’origine dell’opera di Bartolini si situi un’esperienza di disarmonia, che può di volta in volta assumere i toni dell’invettiva sarcastica, del lamento pessimistico e mortuario o della schermaglia amorosa a sfondo aggressivo-cupo. […] La struggente rievocazione di un tempo concluso si accompagna alla percezione dell’apocalittica distanza che lo separa dall’indifferenza del presente. È Bartolini stesso poi a dirci le ragioni della sua poesia in dialetto: Non ricordo l’inizio, ricordo soltanto che una volta tornai da Roma in Friuli e trovai, dopo circa un anno, tutto terribilmente cambiato, a cominciare dalla topografia agricola, quella dei campi, di questi campi completamente trasformati perchè era stata tolta quella caratterizzazione che li rendeva geometrici, le parallele dei gelsi, dei morars. […] Spariva il Friuli della mia memoria, dei ricordi della mia infanzia, e veniva fuori una terra uniforme, di dimensioni pseudo americane, quella delle campagne dell’Illinois, attorno a Chicago, tutte a mais, e adesso a mais e soia. […] E scrissi un gruppo di poesie che chiamai protestantis, si, Poesiis protestantis, come no! E lì cominciò tutto. Protestantis perchè? Voi sapete che si protesta per due motivi, per due ordini di cose: si protesta per qualcosa che s’è perduto e che si vorrebbe riavere, come nel mio caso, o per avere qualcosa di meglio di quello che si ha al momento. Questi due significati confluiscono e si sposano perfettamente, indicano con esattezza qual era il mio stato d’animo, in queste Poesiis protestantis.
(Colors da li vos, a cura di Pieluigi Cappello, Associazione Culturale Colonos, 2006).
Novella Cantarutti è nata nel 1920 a Spilimbergo ed è stata per un primo periodo compagna di strada di Pasolini. Da lui contattata con una lettera datata 7 dicembre 1945 per chiederle alcune poesie per il numero postbellico dello “Stroligut”, la Cantarutti ha poi proseguito il suo ricco cammino dialettale all’insegna di una poesia scavata nell’essenzialità che è fotografia musicale del paesaggio, pulita ed essenziale, che fa di una lingua dura quale il friulano, e nello specifico la sua declinazione dialettale di Navarons, un canto. È la Cantarutti stessa a darci una definizione della sua poesia: I anzalàz (gli angiolacci), spiriti ritrosi, intimiditi dalla luce celeste, che Dio ha collocato in un remoto granaio del paradiso, vicino alla terra. Hanno ali, come tutti gli angeli, ma piccine, arrugginite, perchè essi osano muoverle appena. Ecco: in poesia io mi sento molto angiolaccio e, più il tempo passa, più avverto, quando le muovo, il cigolio delle piccole che arrischiano solo brevi voli perchè assidui, in quel granaio tra terra e cielo che mi va essere la vita d’ogni giorno divisa tra una cattedra, un pullman, un tavolo, anzi una finestra. Con quella ho debiti forti: alta com’è e aperta sui monti mi fa sentire piantata nel mio elemento, meno fuori di posto di quanto io non sia sempre tra la gente, i muri o sulle ruote. Eppure i versi me li suggerisce spesso la strada, me li permettono il seggiolino del pullman, il tempo disoccupato del mio tragitto giornaliero tra Spilimbergo e Udine.
(Polvara e in fiore, Arti Grafiche Friulane 1989)
Gian Mario Villalta, nato a Visinale nel 1959, insegnante, noto per la direzione artistica di Pordenonelegge oltre che per i suoi interventi critici e le pubblicazioni in prosa e poesia, ha condiviso con Pasolini il concetto di morte del dialetto pur affermando che esiste un dato oggettivo inconfutabile: quelle parole dimenticate hanno generato – non si sa come né perchè – una sorprendente esplosione di poesie con la maiuscola, grazie a una folta schiera di “neodialettali” che nell’ultimo trentennio del Novecento hanno prodotto testi meritevoli della massima visibilità. (Figli di un dialetto minore? I poeti in dialetto nati dopo il ’45, Atti del Convegno Internazionale, Trieste 2006). Un dialetto che è lingua dimenticata che sopravvive grazie alla sua sostanziale autonomia. Di Villalta Giacomini ha scritto: Il codice linguistico del tutto marginale che usa (il suo “dialettaccio” come dice) risulta un fatto prioritario in Vose de vose, l’importante libro pubblicato nel 1995. Il venetoide di Visinale è infatti per lui la “materia” dentro la quale implodere per cercare le ragioni per cercare le ragioni dell’esserci di un mondo che fu zoccolo duro del suo; lo analizza cioè come “corpo” in un presente ereditato da una cultura cancellata di cui rimangono tracce percettibili soltanto dalla lucida attenzione di una poeta. Il visinalese insomma, il calare in esso, diventa per Villalta ideale idioletto di un particolare individuo che, piuttosto scettico quando non ironico, lo analizza dal come attualmente è, al come era quando poteva avere motivazioni reali (quando coincideva cioè con cose e fatti concreti della vita d’ogni giorno).
(Tanche giuautis. La poesia friulana da Pasolini ai giorni nostri, Amedeo Giacomini, Associazione Culturale Colonos 2003).
Giacomo Vit è nato a San Vito al Tagliamento nel 1952 e attualmente risiede e lavora come insegnante a Cordovado (Pordenone). Professione questa che si lega intimamente e in maniera riuscitissima con la sua poesia che, slegandosi dal territorio, percorre più la storia e l’identità (o meglio la perdita di identità) di un popolo che è tutti i popoli nella metafora dei bambini. Giacomo Vit canta in un linguaggio particolarmente levigato le tragedie dei bambini attingendo al dialetto come fosse la lingua dei piccoli, e in questo degli uomini che tutti hanno dentro quei piccoli. Di lui Nelvia di Monte, altra ottima poetessa friulana, ha scritto: Il senso di precarietà – insito nel traslocare da una casa ad un’altra, da un periodo della vita ad un altro – è un’eco che si diffonde in cerchi sempre più ampi, fino a inglobare diversi modi di abitare e le corrispondenti condizioni di vita di tante persone. Dal piccolo spazio (“il me toc di paradìs – il mio pezzo di paradiso”) di chi in carcere non ha nemmeno una cella per sé; alla “porta sul cielo” dell’amico poeta scomparso, che aveva dipinto un cielo azzurro attorno all’uscio forse per far capire che “ogni sogno / ha una porta / che noi dobbiamo / aprire”. Fino al testo che chiude la silloge, in cui l’esperienza attuale del poeta si ricolloca dentro l’incessante esperienza di migrazione che unisce il padre e il figlio in una storia che continua a dipanarsi senza fine, come in una dimensione da fiaba cui manchi un punto conclusivo ma tutto resti aperto nei puntini di sospensione. All’interno di questa ampia cornice di condivisione, i riferimenti personali non si chiudono nell’intimismo ma si declinano con una luce obliqua, spesso mediati dai filtri della distanza e dell’ironia, dell’amarezza, delle domande senza risposta poiché è inutile chiedersi “quale montacarichi / avrà la forza / di spostare quintali / di delusioni / accumulate agli angoli della camera?”. La lingua usata è un friulano colloquiale, mai lirico in sé ma che sa far scaturire dalla concretezza delle immagini l’intensità lirica di alcune situazioni, la vena elegiaca di un infinito andare come relitti trascinati dalla corrente, “roba imbombada di sun, / ciapada sù di sbusinòn – oggetti inzuppati di sonno / raccolti in fretta”. C’è a volte una umanizzazione delle cose (“finestre, occhi / inchiodati sul mondo”; “la pelle dei muri / fatta più dura”) che contribuisce a creare un’atmosfera di compenetrazione tra realtà esterna e interiorità, in un clima di forte partecipazione emotiva ma ancorata ad una salda percezione del proprio esserci storico, dell’inevitabile posizionarsi dentro un destino sovrandividuale che trova un punto fermo – non di stabilità ma di autenticità – nella adesione ad una lingua che riconduce ad uno spazio fisico e antropologico di appartenenza, con la quale si può esprimere la parte più intima della propria umanità.
(prefazione a Sanmartin, Giacomo Vit, Lietocolle 2008).
Ida Vallerugo è nata nel 1946 a Meduno dove tutt’ora vive e lavora, come Giacomo Vit, insegnando. La sua poesia non rimpiange anche quando rimpiange un Friuli perduto, una lingua dimenticata, proprio in virtù di una capacità di ricostruzione della lingua che rende la poetessa di Meduno una delle più alte fra tutti i poeti friulani. Una ricostruzione del linguaggio che adotta simboli, crea mitologie, emblemi. Una poesia metafisica si potrebbe quasi dire che, avvicinandosi alla posizione di Tavan per quanto riguarda la geografia e alla posizione di Vit per quanto riguarda il tempo, parte da Meduno per raggiungere l’Australia, Londra, Parigi, fino a tornare a quella Meduno emozionale e originaria che fa del paesaggio e dei suoi abitanti un vero e proprio logos con cui confrontarsi. Sempre Giacomini, sulla Vallerugo, così si esprime: poeta autentico, un “trovatore” che sa vivere le proprie maschere (le proprie proiezioni interiori) in un “trobar clus” apparentemente districabile, ma ricco d’una sapienza formale e di una cultura di fondo abbastanza non comune oggi nella lirica nostra e non soltanto di quella neo-dialettale. È la vita vera lo sfondo sofferto e non troppo segreto dei suoi canti: una vita di sole crisi che, nel presente, nei suoi slogati “moderni” valori, convergenti tutti nella sola superficie, rifiuta, e quella di un mondo contadino al culmine almeno dell’insoddisfazione, riguardante il passato, che ella giudica a caldo (col cuore) facendolo coincidere con pochi “ritratti”, simboli di miti e di riti ormai perenni nella storia personale nostra e sua, ma che, tolta la “pietas” che la guida, non condivide.
(Tanche giuautis. La poesia friulana da Pasolini ai giorni nostri, Amedeo Giacomini, Associazione Culturale Colonos 2003).
Pierluigi Cappello, poeta friulano ormai notissimo per aver vinto il Viareggio, per avere avuto addirittura un film sulla sua vita (Parole povere di Francesca Archibugi). Una vita chiusa e aperta, in qualche modo similmente a Federico Tavan, nella sua Chiusaforte. Nato nel 1967 attualmente vive a Tricesimo, vicino a Udine. Per capire la sua poetica ottime sono le parole stesse di Cappello in occasioni della laurea Honoris Causa a lui conferita dall’Università di Udine: I temi che ho affrontato sono sempre quelli. Fondamentalmente mi interrogo su che cos’è l’ ‘altro da me’ e quali siano i modi di percepire questo ‘altro’, su quale sia il rapporto con il tempo e come cambiano le modalità dell’esistenza. L’infanzia, ad esempio, nei miei versi, rappresenta una realtà intonsa, pura, la meraviglia di fronte al mondo, l’unità perduta con le cose. Non esiste infatti soluzione di continuità tra un bambino e ciò che egli tocca. Ma l’infanzia , in fondo, rappresenta una terra che non esiste. L’evoluzione della mia scrittura riguarda piuttosto la forma. Anni fa ero più vicino a forme metriche definite. Per esempio, in friulano ho scritto diversi sonetti ‘minori’, utilizzano versi settenari. Oggi queste griglie metriche si sono aperte, utilizzo versi lunghi, con un passo quasi narrativo”. A proposito dell’uso del friulano: lei scrive versi sia in marilenghe che in italiano. In base a quale criterio sceglie quale lingua usare? “Cito Ungaretti: ‘non bisogna mai forzare il corpo di una lingua’. Ogni lingua ha sue caratteristiche precise, che connotano un idioma rispetto all’altro. L’italiano è duttile e flessibile, ‘liquido’ direi, con le sue parole piane si presta alla poesia e al canto. Il friulano è crepitante, fatto di parole tronche mono o bisillabi, ma ha il vantaggio di essere molto vicino ai fenomeni naturali. Ci sono argomenti che si possono catturare più facilmente con una lingua piuttosto che con l’altra”. Come nasce una sua poesia? “Ogni poesia è un lungo lavoro di appunti. Quella che si chiama ‘ispirazione’ io la affido all’appunto fulmineo annotato su qualsiasi superficie che si presti alla scrittura, da una busta usata al mio moleskine. Da un insieme di appunti si passa a un lavoro molto tecnico sulle parole, ognuna con le la sua propria tonalità e intonazione. In questa fase si individua subito se una parola stona accanto a un’altra e perché. Con questa ricerca di parole mi piace riempire completamente la pagina, scrivere di traverso, maltrattare persino il foglio bianco. È un momento intenso e per me fondamentale nella creazione di una lirica”.
Federico Tavan infine è nato ad Andreis nel 1949, dove è morto nel 2013, e fin da piccolissimo ha subito l’avvento maledetto/benedetto della malattia mentale. Che poi la malattia, con l’occhio maggiormente consapevole dell’oggi, abbia potuto subire essa stessa aggravi a causa di elettroshock vari, questo non lo sappiamo ma possiamo pensarlo. Certo è che Federico Tavan era un uomo inadatto al mondo, diverso, straniero, alieno. Puro, innocente nel suo essere continuamente e fondamentalmente un bambino che, scontrandosi con l’età che avanzava, diventava l’imponenza di un omone sporco e barbuto che urlava e gesticolava in maniera ingestibile. Una personalità fragile che ha vissuto intensamente l’attimo poetico non solo scrittorio (forse il meno pesante) ma anche promozionale della propria poesia, grazie all’encomiabile interessamento di personaggi friulani che ne hanno fatto a ragione un’icona che a tutt’oggi fa discutere (di ieri il dialogo in giunta a Pordenone sull’intitolazione a Federico Tavan di zone urbane cittadine). Interesse che poi è diventato un aiuto economico attraverso la legge Bacchelli (a tutt’oggi ancora non concessa a Cappello nonostante il suo stato economico fortemente disagiato). Di lui, er concludere questo articolo, Ida Vallerugo ha scritto: Come dire con parole brevi e semplici della poesia di Federico? Di quel suo grido lacerante e nuovo che ha attraversato la cultura friulana. Ma la palude è rimasta, come altre volte, per altri, fedele a se stessa. Come dire di questo Menocchio moderno, che gira per le strade facendo a pugni col nulla? Che ha in sé grazia, e verità, eresia e rogo. Cosa dire di Federico, questa nostra preziosa eresia? Come dire di Federico che a undici anni ha scritto la sua prima poesia in italiano, non in friulano perchè la scuola rigettava i dialetti, e diceva così: “Quante volte ho sperato di leggere nell’aria la parola fine?”. […] Per sua stessa dichiarazione egli è la pantiana, la pantegana, brutta, sporca, pelosa, che vive in basso, nell’inferno delle fogne della solitudine fra gente che non ha storia se non quella delle pedate che prende. Tra pantianes, appunto, che tutti con la loro presenza infastidiscono, ma si badi, quella gente, quelle pantianes hanno la grazia della divinità, sono per la coscienza del mondo ciò che lui stesso è, voce di cràcela, la raganella di legno che il venerdì santo sostituisce il silenzio delle campane. È, in definitiva, la poesia.
(Federico Tavan nostra preziosa eresia, Ida Vallerugo, Forum Editrice 2008)
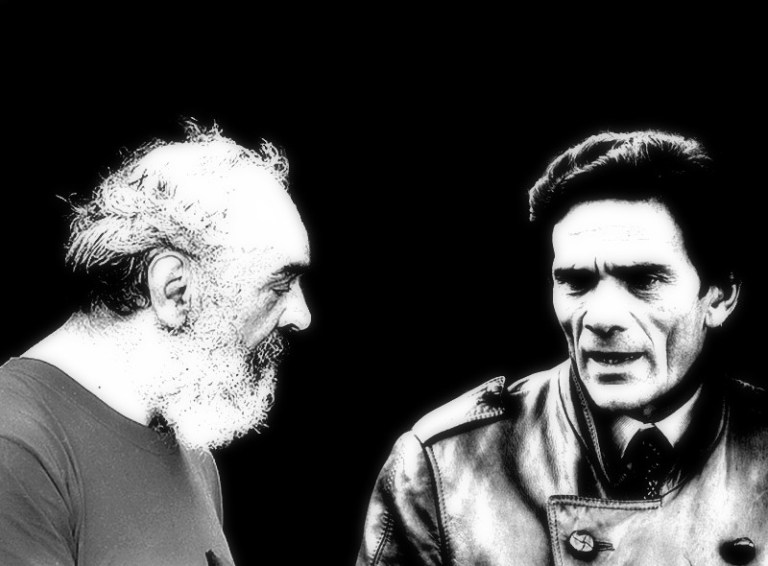
3 pensieri su “La poesia dialettale friulana dopo Pasolini”